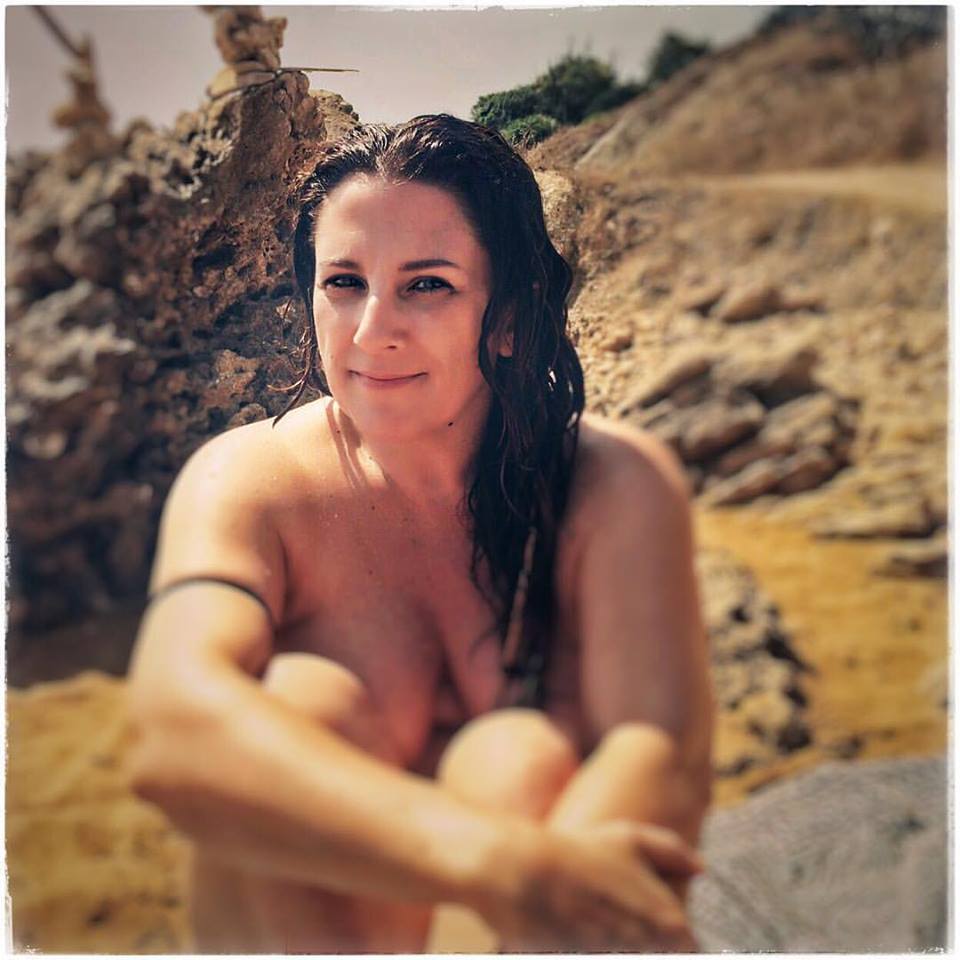Una volta si può anche piangere
Io, il giorno dopo il suo funerale, sono partita. E’ successo un anno fa.
Avevo programmato da tempo quel viaggio e tra gli appuntamenti ce n’era uno particolarissimo: ero riuscita a trovare un posto per andare a vedere il Cenacolo di Leonardo da Vinci. Lo avevo detto a mio padre e lui contentissimo mi aveva risposto, sgranando gli occhi, “Che culo!“. Ero già stata a vederlo una volta perché, da piccola, era stato lui a portarmi e ricordo che allora non c’erano file, non c’erano prenotazioni, non c’erano controlli, non c’erano tempi di visita da rispettare. C’era solo il dipinto, a due passi dai visitatori, che quasi si sarebbe potuto toccare. Non avrei potuto rinunciare a vederlo una seconda volta, soprattutto in quella seconda volta, tre giorni dopo la sua morte. Non avrei potuto perché lui mi ha insegnato ad apprezzare l’arte, perché ci ha portato in giro per l’Italia a conoscerne le bellezze (“Prima di andare all’estero bisogna conoscere bene l’Italia“), non avrei potuto perché lui avrebbe fatto esattamente come me.
In una rapida riunione di famiglia abbiamo deciso che la mia partenza non avrebbe creato problemi, anche se li stavo abbandonando nel momento peggiore, forse, quello delle visite dei parenti e degli amici. Ma loro, che mi conoscono, sanno quanto sia vitale per me respirare arie diverse, arie nuove, quanto sia importante che io svuoti periodicamente lo stagno che ho dentro e lo riempia con acqua fresca e pulita.
Ho messo un vestito rosso, ho preso la borsa rossa, ho riempito la mia valigia rossa e sono partita.
Il Cenacolo era bello come non l’avevo mai visto. Sono rimasta seduta lì davanti per tutto il tempo che la visita mi concedeva. L’ho osservato nei minimi particolari. Me lo sono gustato in pieno, pensando a come l’avrebbe guardato lui se quel giorno avesse potuto farlo. E mi sono riempita gli occhi di quella luce che le tre finestre dipinte al centro della scena, incuranti dei secoli che sono passati, ancora diffondevano nell’ambiente. Una luce da cui non si poteva distogliere lo sguardo. Netta, pulsante, viva. La luce di cui avevo bisogno.
 Ho rivisto quella luce riempire il cielo di una mattina di luglio, mentre facevo colazione:
Ho rivisto quella luce riempire il cielo di una mattina di luglio, mentre facevo colazione:
“Oggi era il compleanno di mio padre. Lo festeggio così, mangiando la sua confettura di more e sapendo di mangiare l’ultimo barattolo.
Ma senza tristezza. Vorrà dire che imparerò a prepararle io, perché le cose, anche se non le sai fare puoi imparare a farle. Me l’ha sempre fatto capire.
Tutto a un certo punto finisce. Quando sei stanco e sai che puoi essere arrivato alla fine, ti metti da parte, con serenità e senza dire niente, chè niente c’è da dire e tutto è stato detto.
Senza tristezza, perché chi se ne va lascia un pezzetto in noi per poterlo ricordare sempre: è nella battuta facile e nel senso dell’umorismo che ha Alberto, è nella mente matematica di Carlo, è nella frenesia creativa e fabbricante di Fabrizio, è nella precisione millimetrica di Federica, è nella mia sfrontata testa sempre alta. È nella forza che ha mia madre Carola. Senza tristezza, io continuerò a mangiare la confettura di more.”
La stessa luce circolava nel sogno dell’altra notte quando ci siamo abbracciati, l’unica volta in tutta la nostra vita.